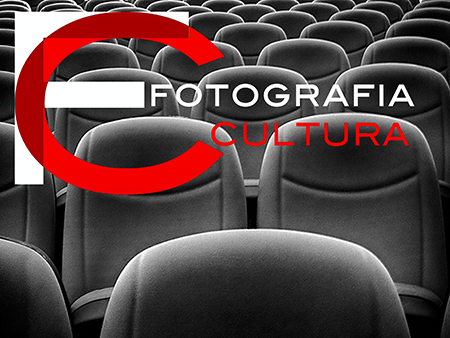TITOLO E DIDASCALIA IN FOTOGRAFIA
Titolo e didascalia sono sostanzialmente la stessa cosa, tecnicamente vengono definiti come “ancoraggi” perché ancorano l’osservatore a una precisa metrica interpretativa della fotografia.
La differenza risiede nel fatto che il titolo è di per sé una sintesi, mentre la didascalia è più discorsiva e consente al lettore di attingere maggiori informazioni. In questa ottica titolo e didascalia possono coesistere.
Questa comunione di lingua e immagine, aiuta l’osservatore ad andare oltre la pura fruizione estetica della fotografia, consentendogli di cogliere significati più profondi legati all’aspetto connotativo dell’immagine e questa funzione apparentemente sembrerebbe dare ragione a Barthes quando, in un primo momento, parlava di fotografia come di messaggio senza codice.
Questo connubio, a mio parere, ha una funzione sociale nella interpretazione della fotografia in quanto consente di colmare il gap culturale tra il fotografo e l’osservatore.
Tante volte abbiamo sentito dire: “Una fotografia deve parlare da sola, altrimenti non è una buona fotografia!”
Ora analizzando la frase notiamo immediatamente che si mette sullo stesso piano la fotografia e la parola, quindi fotografia come linguaggio che, in linea teorica, dovrebbe essere autoreferente.
Tuttavia esistono fotografie in cui la componente connotativa per essere compresa, richiede un retroterra culturale di alto livello, che non è certamente appannaggio di tutti e, pertanto, la parte verbale è il veicolo dell’indessicabilità nascosta della fotografia.
Facciamo un esempio pratico:
Come si può chiaramente osservare le fotografie di Hiroshi Sugimoto ad un primo esame appaiono di una banalità unica, non solo, ma con la linea dell’orizzonte esattamente a metà del fotogramma, anche deprecabili da un punto di vista delle regole estetiche.
Leggendo la sua didascalia, al contrario, noi siamo indirizzati verso una visione filosofica particolarmente complessa e articolata e quindi riusciamo ad attribuire alle sue fotografie significati molto più profondi e finalmente possiamo fruire della chiave interpretativa per riconoscere quell’aspetto connotativo che le eleva ad arte.
Da qui la forza e l’utilità della didascalia che rendere socialmente fruibile una fotografia di alto valore, che verrebbe altrimenti ghettizzata da uno sbrigativo “brutta”, giudizio caratteristico di quella che Umberto Eco definiva “Massculture”.
Tuttavia esistono anche distorsioni dei titoli e delle didascalie. Esse avvengono soprattutto quando sono scritte da persone diverse dal fotografo, per farne un utilizzo sociale fraudolento, come avviene – e spesso è avvenuto – da parte di alcuni organi di stampa.
L’utilizzo funzionale ad una chiave di lettura ideologica e non interpretativa del vero aspetto contenutistico, significa quanto meno mistificare il messaggio connotativo e forzare l’osservatore verso una chiave di lettura non solo avulsa, ma spesso addirittura contraria al contenuto fotografico.
Di esempi, a questo proposito, se ne trovano moltissimi e forse il più clamoroso è quello della rivista “L’Express” che nel dicembre del ‘56 pubblicò due volte lo stesso reportage sulla rivolta ungherese, accompagnandolo da didascalie diametralmente opposte, dove in un articolo sosteneva le ragioni degli invasori e nell’altro quella del popolo aggredito.
L’esperimento voleva dimostrare come le fotografie da sole non abbiano la capacità di trasmettere correttamente un messaggio,
Ora, di fronte a questo esempio, non possiamo che concordare sulle conclusioni, ma possiamo sottolineare come titolo e didascalia abbiano una funzione di intermediazione socio-culturale.
Dobbiamo però anche prendere atto che esse hanno una loro validità solo e unicamente se scritte dal fotografo autore delle immagini, l’unico che possiede il codice corretto per la loro decriptazione, altrimenti essere divengono ostaggio di interpretazioni personali dell’osservatore e perdono completamente la loro funzione e il loro significato.