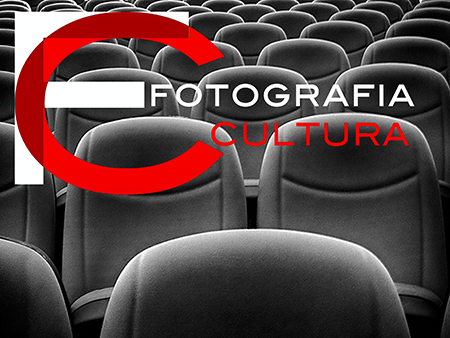LA FOTOGRAFIA ICASTICA

Da Platone[1] e “Le ragioni dell’immagine”:
“L’immagine in generale, icastica o fantastica che sia, esiste dunque ed è tale a patto di essere “immagine di … ” dunque di non essere ciò di cui è immagine; essa è, per ciò stesso e in quanto ‘immagine’, sempre, strutturalmente, “falsa”.
In realtà l’immagine icastica, poiché – nel riprodurne proporzioni e colori naturali – è fedele al modello, è “somigliante” a esso, vale a dire poiché conserva un rapporto, ricostruibile comunque, da ogni possibile osservatore, col modello stesso, a esso rinvia costantemente e dunque ne consente il riconoscimento.
L’immagine fantastica invece, essendo riproduzione non della cosa come è, ma della cosa come appare, tende a velare il proprio rapporto col modello, a proporsi essa – immagine apparente – come unico “reale”, non come “immagine di” altro.
La “falsità”, il non essere, nei due casi si gradua quindi a livelli diversi d’intensità: nel caso dell’immagine fedele, essa, in quanto immagine, non è, ma si dichiara un’immagine, cioè dichiara il proprio non essere, rimandando ad altro (è “falsa” e però svela di esserlo); nel secondo caso, l’immagine fantastica in quanto immagine del pari non è, ma tende a nascondere il proprio essere un’immagine e dunque il suo stesso non essere, a proporsi essa come unico “vero” (è “falsa”, ma nasconde di esserlo).
Perciò la prima può dirsi immagine “vera” (poiché svela il proprio non essere il modello, nel momento in cui permette di riconoscerlo) e la seconda va detta invece immagine “falsa” (perché si muove a nascondere il modello, a sostituirlo, a prenderne il posto, negando il suo stesso essere ‘immagine di … ‘). La “falsità” dell’immagine che non si svela tale, che nasconde il proprio essere immagine, è dunque esattamente, qui, quella, ingannevole, dell’ombra della caverna platonica non riconosciuta per un’ombra, o quella dell’èidolon dell’Elena euripidea non riconosciuto per un semplice fantasma.”
Ecco una definizione efficace d’immagine icastica, che se traslata in ambito fotografico ci consente di definire “icastica” quella fotografia che rappresenta la realtà oggettiva senza alcuna intermediazione, che può essere letta da qualunque fruitore senza sforzo e senza fraintendimenti.
Da un punto di vista semantico potremo assimilarla alla fotografia “sostanziale o documentale”, o, per richiamare Barthes[2], potremmo definirla come un “messaggio senza codice”, anche se tale accostamento non è proprio calzante, considerando che la fotografia icastica, comunque, un quid connotativo lo potrebbe avere, come vedremo più avanti.
Pertanto volendo riassumere quella che potrebbe essere la definizione di fotografia icastica, dovremmo intendere quella fotografia che riprende in modo assolutamente oggettivo la realtà che si presenta di fronte al mirino e che, successivamente, è proposta al fruitore senza alcuna manipolazione intermedia.
Una prima questione riguarda l’esistenza reale delle fotografie icastiche.
Sotto il profilo della realtà oggettiva sicuramente le immagini icastiche esistono, tuttavia, osservando il problema sotto l’aspetto storico-critico, sembrerebbe che non esistano, non esistono proprio, preso atto che nessuno, fino ad oggi, ha mai utilizzato questo termine per un loro inquadramento tassonomico, almeno per quanto ho potuto appurare.
Alla luce di quanto sopra, mi sembra opportuno illustrare quali, secondo me, sarebbero i paradigmi “ideali” – e sottolineo: ideali – che fanno di un’immagine fotografica una fotografia icastica. Semplificando ne ho focalizzati tre:
- L’intervento del fotografo deve essere ridotto al minimo, cioè egli dovrebbe limitarsi a una scelta dell’inquadratura che sia avulsa da ogni sua impostazione culturale, mentale o sociale.
- Nessun intervento di manipolazione dell’immagine dovrebbe intervenire nella fase di postproduzione.
- Nessun intervento di ritaglio dell’inquadratura o di aggiustamento topologico dovrebbe alterare l’immagine.
Analizzando queste regole che, lo sottolineo, rappresentano l’idealizzazione di fotografia icastica, devo ammettere che ben difficilmente si possono realizzare, almeno tutte e tre contemporaneamente.
Analizzando il primo punto, sorge spontanea una domanda: può realmente un fotografo essere così accorto da non intervenire in alcun modo nella fase di ripresa? Personalmente ritengo che la risposta sia negativa. Nel momento in cui egli mette in moto l’atto fotografico, inevitabilmente, non è più “oggettivo”. Egli sceglie cosa inserire nella sua fotografia e cosa escludere e già pone in essere un elemento perturbatore.
Voglio comunque precisare la differenza tra realtà oggettiva e oggettività, considerando che molti confondono i due termini: con realtà oggettiva s’intende tutto quello che sta di fronte all’obiettivo e che la macchina da ripresa registra. Con oggettività si fa riferimento all’interazione tra il fotografo e la realtà oggettiva, cioè alle scelte che il fotografo pone in essere nel decidere l’inquadratura che più corrisponde al suo sentire interiore, culturale, sociale, ecc..
Ora analizzo come questa sua opzione possa conciliarsi con una fotografia icastica. Volendo fare un esempio banale di vera fotografia icastica, potrei proporre quella che s’imprime quando si preme involontariamente, per errore, il pulsante di scatto, senza avere coscienza di aver inquadrato, ma ciò ovviamente presuppone uno sbaglio e l’operatore subito eliminerebbe il fotogramma. Questa incarna certamente una situazione limite; molto più realisticamente rivolgo il mio pensiero a quelle fotografie in cui l’intervento dell’operatore è minimale.
Intendo riferirmi a quelle fotografie nelle quali l’intervento del fotografo, nella fase di ripresa, ha come finalità di rendere la realtà esterna nel modo più oggettivo possibile.
Analizzando le varie tipologie d’immagini fotografiche, credo che quelle che, dal punto di vista storico, meritino di entrare nel novero delle fotografie icastiche, siano le fotografie “post mortem”. Si tratta di riprese che, soprattutto nell’ottocento e ai primi del novecento, erano commissionate a fotografi ambulanti per possedere un ricordo del proprio caro defunto, così da tramandarne la memoria e da mostrare ai parenti lontani (da queste esigenze trasse origine l’usanza delle immaginette funebri, che usiamo ancora oggi). In queste fotografie l’intervento del fotografo era minimale, nel senso che la fotografia doveva rispecchiare una realtà oggettiva, senza molte intermediazioni, se non quelle relative alla preparazione del defunto, ma che secondo me non rappresentano interferenze nella realizzazione dell’immagine.
Nell’ambito della fotografia odierna penso che un utilizzo della fotografia icastica riguardi quelle immagini documentali proprie della polizia scientifica. In questo caso è essenziale che il fotografo limiti al massimo ogni interferenza soggettiva al fine di evitare un inquinamento delle prove e che possa presentare una visione il più possibile realistica della scena del crimine; qui di seguito abbiamo alcuni esempi:
È evidente che in queste fotografie l’intervento da parte del fotografo è assolutamente marginale, anzi io parlerei quasi di auto-fotografia, assumendo che il fotografo non sceglie di inquadrare interpretando dei suoi canoni estetici o culturali, bensì è obbligato a seguire rigorosi protocolli imposti dalla situazione oggettiva e dal carattere documentale proprio dell’immagine.
Un’altra fotografia sicuramente inquadrabile in questo ambito è la fototessera e quella segnaletica:
In queste fotografie l’intervento umano è sostanzialmente inesistente, considerato che la macchina fotografica opera in modalità automatica e senza necessità di un operatore, dando così il massimo valore icastico all’immagine.
Questa tipologia di fotografia ha ovviamente lo scopo di dare una riproduzione fedele e asettica del soggetto ritratto, senza alcuna valenza mitica, anzi lo scopo identificativo spinge la persona ritratta ad assumere un’espressione neutra, impersonale e ne destruttura la personalità rendendola assolutamente impenetrabile; inoltre l’immagine comunica con immediatezza quei caratteri fisici che permettono, grazie a un meccanismo di banale comparazione, il riconoscimento della persona da parte del fruitore senza ulteriori mediazioni.
Come altro esempio di fotografia icastica devo citare anche la fotografia pornografica, che per il tipo di messaggio veicolato, rappresenta forse il vero “grado zero” di questa specie.
Un problema rilevante relativamente all’inquadratura, tocca profondamente anche il reportage e il fotogiornalismo. Come scrisse W. Eugene Smith:
“Quelli che credono che il reportage fotografico sia “selettivo e oggettivo”, ma non possa decifrare la sostanza del soggetto fotografato dimostrano una completa mancanza di comprensione dei problemi e dei meccanismi propri di questa professione. Il foto-giornalista non può avere che un approccio personale ed è impossibile per lui essere completamente obiettivo. Onesto sì, obiettivo no.”.
Io interpreto il termine “onesto” in senso icastico, cioè nel senso che il fotografo restituisca un campo inquadrato tale da non indurre in errore il fruitore, consentendogli una corretta lettura dell’avvenimento. Obiettivo no, lo spiego come la libertà del fotografo di scegliere quale avvenimento documentare.
Un esempio illuminante è proposto in questa immagine che, pur essendo di fantasia, descrive molto bene quello che succede nel fotogiornalismo:
È evidente come la manipolazione dell’inquadratura possa veicolare messaggi ben diversi e come, pertanto, sia quanto mai necessario che la fotografia di reportage sia assolutamente icastica
Come ho accennato prima, parlando di Barthes, la fotografia icastica non sottintende sempre un “messaggio senza codice”, cioè una carenza connotativa, anzi in alcune situazioni essa è espressione aspetti contenutistici di grande spessore.
È il caso, per esempio, delle immagini di August Sander che per esprimere fotograficamente la filosofia della corrente artistica “Neue Sachlichkeit”, si è trovato a riprendere le persone sfruttando il massimo dell’oggettività e della neutralità espressiva:
Motivazioni analoghe sono sottintese nella fotografia tassonomica della scuola di Düsseldorf dei coniugi Becher come nella serie dei gasometri:
Infine citerei anche Warhol che con le sue riprese a imitazione di fototessera, si messo alla ricerca di una fotografia oggettiva e spogliata di ogni interferenza sia da parte del fotografo, come del soggetto ritratto:
Prendendo in esame il secondo paradigma e calandomi nella realtà odierna della fotografia digitale, mi trovo di fronte ad un problema serio: quali dovrebbero essere le caratteristiche di una fotografia icastica, ad esempio, in bianco e nero? Purtroppo in questo caso per produrre un’immagine icastica pura, il fotografo dovrebbe ricorrere a costosissimi apparecchi da ripresa che operano direttamente in bianco e nero, oppure limitare al minimo indispensabile l’intervento di trasformazione (ma qui naturalmente potrebbero sorgere molte polemiche).
In caso contrario, rimane inevitabile il ricorso alla pellicola.
Innegabilmente il dilemma esiste e, sebbene non cancelli la possibilità di creare un’immagine icastica pura, certamente pone dei problemi di “purezza”, anche perché utilizzando l’elaborazione elettronica, difficilmente il fotografo resiste alla tentazione di alterarla con mascherature o quant’altro, manipolando così il messaggio in ingresso.
Anche per le fotografie a colori, comunque, esiste la possibilità di una loro manipolazione: anche solo un’esaltazione della saturazione, che ha una sua valenza semantica ben precisa, può inquinare la fotografia icastica.
Pertanto, se restiamo in un ambito di purismo assoluto, ben difficilmente potremmo mai osservare una fotografia realmente “icastica” eseguita con i moderni apparecchi digitali. Tuttavia, considerando che, come ho scritto sopra, anche la fotografia icastica può veicolare elementi connotativi, ho la convinzione che il fotografo sia in grado di produrre immagini icastiche intervenendo con manipolazioni minimali, limitate alla conversione “bruta” dell’immagine in B/N o alla correzione delle aberrazioni cromatiche come la correzione del tono del bianco.
Venendo all’ultimo paradigma che, in fondo potremmo considerarlo un corollario del primo, direi che, al contrario, ha una sua specificità.
Come ben sappiamo, lo spazio inquadrato, facendo riferimento al classico saggio di Dubois[3], consiste in uno spazio “sottratto” alla realtà da parte dell’operatore e in uno spazio topologico, proprio dell’osservatore, che vi riconosce una “realtà”, tante volte bugiarda. Per spiegarmi meglio: il fotografo, inevitabilmente, sceglie cosa inquadrare poiché la fotografia per sua natura procede per sottrazione, cioè l’operatore sceglie di inserire nel fotogramma solo una porzione della realtà che ha di fronte, e quindi la sottrae, anche se, con artifici di tipo psicologico, egli può dare al fruitore alcune informazioni, contenute all’interno del campo inquadrato, che gli consentono di ricostruire mentalmente anche il “fuori campo”. E fino a qui nulla inficia il carattere icastico di una fotografia: l’inquadratura è un processo normale e inevitabile e la fotografia stampata nella sua interezza diviene il campo topologico del fruitore, in altre parole quello che vediamo nella fotografia stampata. Però se il nostro fotografo interviene a posteriori ritagliando l’immagine, allora tutto cambia!
Faccio una piccola digressione solo per menzionare Alfred Stieglitz che per primo comprese la possibilità, allora avente solo fini estetici, di poter ritagliare la fotografia per conferirle un significato differente. Famosa la prima della Fifth Avenue a New York sotto la neve, anno 1893:
Il significato, in questo caso, cambia e di molto! Pensiamo allora quando questa manipolazione viene fatta con finalità comunicative a livello di media come succede spesso e, nel qual caso, chiaramente non possiamo più parlare di fotografia icastica.
In definitiva, con il termine di “fotografia icastica” intendo proporre un inquadramento tassonomico per quelle immagini in cui vi sia una riproduzione della realtà di fronte all’obiettivo, proposta riducendo al minimo possibile le interferenze legate alla personalità del fotografo e depurate, nel limite del possibile, da ogni intervento in post produzione e proposte direttamente al fruitore, che deve poterle leggere con immediatezza e relativa facilità. Quindi questo termine dovrebbe definire tutte quelle fotografie il cui scopo è, prevalentemente, documentale e quindi anche la fotografia di reportage o fotogiornalismo.
Prendendo spunto dal pensiero di Gianni Berengo Gardin, che sostiene che la vera fotografia non è arte, ma documento, anche se questa sua interpretazione non è scevra da spunti critici, occorre tuttavia dargli ragione, nel momento in cui quello che viene presentato al fruitore, non può prescindere da una realtà oggettiva.
Nonostante ciò la fotografia icastica non è così ingenua da essere priva di quid estetico, ma questo trova il suo limite nell’automatismo del fotografo che ha la facoltà di seguire la regola dei terzi e delle geometrie in gioco, non interferendo con esse, ma cercando un punto di ripresa “armonico”, che non sovverta la realtà esterna.
La fotografia icastica, poi, non necessariamente deve autolimitarsi a messaggio senza codice. Essa, come ho menzionato a proposito di Sander, dei Becher e di Warhol, può racchiudere aspetti connotativi di grande rilevanza e quindi non proporsi come espressione del banale e del superficiale. In questo caso il fruitore necessita di un background culturale significativo per poter leggere con disinvoltura l’immagine, ma questo dovrebbe rappresentare la norma per tutti.
In conclusione l’introduzione del termine “fotografia icastica”, non è a mio parere un pleonasmo, ma consente di focalizzare con precisione un certo modo di fare fotografia, che prescinde dalla pretesa di produrre “Arte”, ma che incarna l’attimo fuggente e porge all’osservatore la verità (io eliminerei il termine verità, troppo impegnativo e ambiguo: si potrebbe sostituire con: “porge all’osservatore un’immagine il più fedele possibile…) quale espressione, il più fedele possibile, della realtà oggettiva.
Icastica dovrebbe essere, come accennato prima, la fotografia del reportage e del fotogiornalismo, che per sua natura dovrebbe proporre al lettore una realtà/verità, non alterata in alcun modo dal fotografo. Questo per mantenere lo status di documento e di credibilità, oggi purtroppo perduto nei meandri di un’estetizzazione soverchiante e dalla ricerca di linguaggi sempre più lontani dalla semplicità icastica e sempre più ammiccanti alle mode del momento.
“Vedere, registrare, mostrare”, a mio modo di intendere dovrebbe essere questo il motto del perfetto fotoreporter e allora molti si chiederanno che differenza c’è, da un punto di vista tassonomico, parlare di fotografia documentale piuttosto che di immagine icastica?
Bene, mentre la fotografia documentale può risentire dell’interferenza del falso, poiché un documento può anche essere falso, la foto icastica esclude assiomaticamente la possibilità di un falso, volontario o accidentale, dando per certo il completo asservimento del fotografo alla realtà oggettiva e alla sua restituzione al lettore senza interferenze soggettive.
Bibliografia
- PLATONE E LE “RAGIONI DELL’IMMAGINE”. Percorsi filosofici e deviazioni tra metafore e miti – Napolitano Valditara Linda M. – V&P Editore
- La camera chiara – Roland Barthes – Einaudi Editore
- L’atto fotografico – Philippe Dubois – Quattroventi Editore