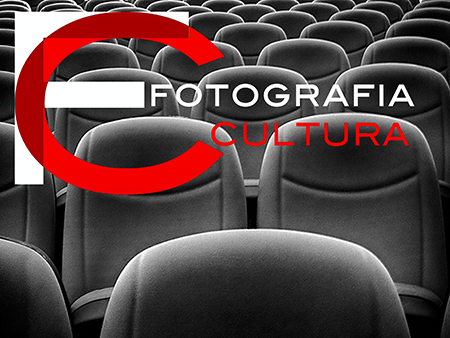ATTRAVERSANDO IL GIARDINO DEL DIAVOLO CON NAN GOLDIN

Una volta il mondo dei bigotti avrebbe definito Nan Goldin, come la “Fotografa maledetta” o “Fotografa del diavolo”, tant’è che lei ha pubblicato “Il Giardino Del Diavolo”, che rappresenta la summa della sua produzione artistica.
Nan nasce a Washington D.C. nel 1953 da famiglia ebrea, ma cresce a Boston, dove la sua passione per la fotografia nasce all’età di quindici anni grazie un insegnante che prestava le macchine fotografiche Polaroid agli studenti della Satya Community School di Boston, che lei frequentava.
La sua vita fu profondamente segnata dal tragico episodio del suicidio della sorella Barbara, diciottenne, nel 1965. La mancata elaborazione del lutto da parte sua e soprattutto della famiglia, che, per vergogna, si rifiutò sempre di affrontare l’argomento (anche con lei), la traumatizzò profondamente. Ella iniziò il suo approccio con la fotografia riprendendo i suoi genitori e parenti, con un atteggiamento puramente documentale, cercando di fissare i suoi ricordi di famiglia; in seguito, emergendo il suo spirito ribelle e incline alla scoperta dell’umanità emarginata, si spinse ad avvicinare e frequentare gruppi di omosessuali e persone ai confini della società, con le quali non solo ne condivise il modo di vivere, ma ne assorbì anche le condizioni sociali e umane, tanto da instaurare un rapporto affettivo e profondo con David Armstrong, omosessuale, con il quale frequentò quegli ambienti iniziando un percorso fotografico in cui il “documento del vissuto” s’incarna profondamente nella sua iconografia.
Molto importante anche il suo rapporto con Brian, che sfociò in atti di violenza, tanto che ella subì un tentativo di omicidio, e che Nan immortalò nel famoso autoritratto “Nan after being battered, 1984”
Qui cito una sua frase che ci riassume molto bene il background del suo essere fotografa:
“Il mio lavoro si basa sulla memoria. Per me è fondamentale avere un ricordo di chi mi è stato vicino, per consentirgli di vivere per sempre.”
Nan ha di fronte alla fotografia un atteggiamento prettamente femminile, tanto che le sue fotografie, nella loro apparente semplicità, assomigliano a quelle di un album fotografico di famiglia.
In esse, però, non troviamo attimi di felice intimità familiare, ma momenti di un vissuto non certo convenzionale o perbenista, anzi in quegli ambienti, che il comune senso del pudore, espressione di una diffusa ipocrisia puritana propria del nord-est americano, tende a relegare nell’ultimo angolo di un mondo considerato come il ghetto dell’amoralità, quello dove, di solito, l’occhio della gente per bene non arriva.
Così la Goldin, ci guida per mano, come Dante nell’Inferno, mossa non certo dallo spirito voyeuristico di chi osserva con intima soddisfazione carnale, per poi emettere sentenze di condanna, ma piuttosto mossa dalla voglia di ricordare frangenti di vita ai quali fu parte e comprimaria.
Tanto comprimaria da produrre molte immagini dove appare lei stessa: non dietro, ma davanti al mirino, divenendo direttamente parte del ricordo, della storia, anche come protagonista. I suoi amici, amiche e parenti sono ripresi in attimi di vita intima, dove Nan non si sente estranea, ma attiva partecipe e non prende mai le distanze da chi le sta di fronte, l’obiettivo non funge da filtro ma quasi scompare grazie alla grande intimità che intercorre fra la fotografa e i soggetti ritratti, a proposito dei quali la stessa ammette:
“Non sono un’imbucata. Questa è la mia festa. Questa è la mia famiglia, la mia storia”
Famiglia e storie che tante volte narrano di sofferenza e disadattamento e che lei ci racconta con la ferma crudezza della realtà documentale. Omosessualità, malattia, violenza sono affrontati con grande coraggio sia in termini di forza d’animo, che iconografici. Ma la sua fotografia non è solo ricordo di violenza, bensì anche momenti di dolcezza, di un istinto materno che lei non ha mai potuto riversare su un suo figlio; ecco che i figli di amici, in tante sue riprese, divengono come suoi. Ella se ne appropria in un abbraccio di amore attraverso scatti che riescono pienamente ad esprimere sentimenti profondi.
Quella della Goldin è quindi una fotografia che possiamo ontologizzare tra la “fotografia documentale”. Ma è proprio così semplice? Vediamolo analizzando le sue immagini.
Questa volta vi propongo la lettura simultanea di ben tre fotografie, che per il loro contenuto, sono, a mio parere, assolutamente assimilabili, non solo, ma inserisco un nuovo elemento nella lettura delle fotografie: l’interculturalità. Ovvero come la lettura di una fotografia ci porti a usare gli stessi parametri per la pittura e a comprendere il legame profondo tra queste due arti, che spesso s’incontrano sia sul piano semiologico, che interpretativo e analitico.

Ingrandisci

Ingrandisci

Osservando le tre immagini salta subito all’occhio che sono accomunate da alcune semplici, ma significative, caratteristiche semiologiche: in tutte sono riprese due persone, una verticale e una orizzontale; tutte le scene rendono la sensazione che tra i due protagonisti vi sia stato un rapporto carnale, ormai esaurito, e che aleggi tra loro un senso di indifferente insoddisfazione; la luce proviene da un unico punto, verosimilmente una finestra; tutte rimandano in modo impressionante al dipinto di Hopper.

A questo punto, considerando la lettura interculturale, devo fare una breve digressione su Hopper.
Edward Hopper fu un pittore della corrente realista e acerrimo critico dell’arte astratta e delle avanguardie, contro le quali dichiarò:
“La grande arte è l’espressione visibile della vita interiore di un artista, e da questa vita interiore nascerà la sua personale visione del mondo. Nessuna abile invenzione può rimpiazzare un elemento fondamentale come l’immaginazione. Una delle debolezze di tanta pittura astratta è il tentativo di sostituire le invenzioni dell’intelletto a una concezione derivante dalla pura fantasia. La vita interiore di un uomo è un regno vasto e variegato e non riguarda solo piacevoli accordi di colore, forma e disegno”
I suoi quadri, apparentemente semplici e d’immediata lettura, in realtà nascondono un continuo slittamento del senso per via di significati costruiti dal suo subconscio, che si rivela in quel non so che di spietato e di amaro che sprigiona da molte delle sue raffigurazioni.
Dal suo quadro ne esce un’umanità sconfitta, una distanza nei rapporti umani che l’amore fisico non riesce a colmare e la depressione è lo stato d’animo che aleggia tra i protagonisti.
Analogamente, ritornando alle fotografie di Nan, sembra di rivivere le stesse sensazioni.
Analizzando l’indifferenza nei rapporti tra gli attori, s’indovina anche uno stato di “quasi disperazione” e che l’unico rifugio di un rapporto non concluso o deprimente, sia l’evasione o l’ignorarsi: delusa evasione altrove o indifferenza sembrano le uniche conseguenze possibili del rapporto di coppia.
La rappresentazione di coppie bloccate nelle loro relazioni e, come scrisse Burchfield, pervase da un silenzio quasi mortale, esprime un certo pessimismo della Goldin nei confronti dell’umanità: se nemmeno nella sfera più intima è possibile una comunicazione e l’apertura all’altro, come pensare che ciò sia possibile nei rapporti sociali?
Ecco quindi come un’analisi psicologica dei rapporti tra i soggetti ritratti e un accostamento a un dipinto ci possono aiutare nell’interpretazione di fotografie e come risulti estremamente stretto il rapporto interculturale tra forme artistiche diverse.
Spingendoci in un’analisi iconopoietica, le tre fotografie narrano proprio questi sentimenti, che si ritrovano anche nel dipinto di Edward.
Entrando più nel dettaglio scopriamo che nella prima fotografia, che è una delle più famose della Goldin, sopra il letto, campeggia il ritratto di Brian, nello stesso atteggiamento attuale: un uomo che fuma, incurante e indifferente nei confronti degli altri e, in fondo, della vita. Ma Nan, che ancora prova affezione, afferma così il sentimento profondo che la lega a quest’uomo, verso il quale prova ancora un’incondizionata venerazione, tanto da trasformarlo in un’icona quasi da adorare. Nel suo sguardo, tuttavia, troviamo un senso di rimprovero misto a paura – non dimentichiamoci che lui tentò di ucciderla -, ma anche la consapevolezza di un rapporto finito. La tensione tra i due è palpabile, in un realismo documentale sconcertante, essa travalica lo spazio topologico e penetra direttamente nell’intimo dell’osservatore rendendolo presente e partecipe. Una capacità narrativa sicuramente non comune e di grande spessore.
Analogamente nella seconda fotografia, che forse si avvicina più delle altre, al contenuto del dipinto di Hopper, troviamo un rapporto interrotto. Tra i due non corre alcuno sguardo, nessuna interazione, così ci viene trasmesso il senso di vuoto affettivo proprio di un amore finito. Anche gli sguardi, assolutamente divergenti, sottolineano con grande enfasi questo stato d’animo. La mano che lei tiene sul polso, come a massaggiare una zona dolente, ci richiama a qualcosa di violento, a una lite; analogamente la posizione dell’uomo ci porta a immaginare lo sfogo dopo un’accesa discussione. Anche qui troviamo la sofferenza e la depressione di un sentimento finito, l’ansia dell’abbandono e la paura della solitudine, tutte immagini proprie di un impulso interiore comune anche alla raffigurazione di Hopper.
La terza fotografia si discosta un po’ dalle altre due. Pur sottolineando il disinteresse dei due soggetti, l’uno nei riguardi dell’altro, qui non si respira un’aria pesante di tensione violenta, sottolineata dall’inversione dei ruoli, cioè la donna verticale e l’uomo orizzontale. Anzi qui l’indifferenza non trova il suo punctum quale estrinsecazione di un sentimento esausto, ma dà la sensazione della conclusione di un formale rapporto di meretricio: lei che si veste e sta per uscire, lui che rovista alla ricerca dei suoi abiti. Si avverte la totale mancanza di trasporto affettivo, come avviene in incontri occasionali e tale percezione è rafforzata proprio da una serenità quasi surreale.
Tre fotografie e un dipinto, uniti da una chiave interpretativa comune, un interscambio di sensazioni affettive che pone tutti sullo stesso piano ermeneutico.
Ma come possiamo noi leggere tanti sentimenti in queste immagini? Quali sono i vari “punctum” che ci guidano?
Innanzitutto il contrasto introspettivo tra verticalità e orizzontalità, la verticalità evoca antigravità, fatica, reazione, ansia; l’orizzontalità quiete, remissione, accettazione. Lo scontrarsi di questi elementi acuisce la percezione della tensione, in particolare se l’elemento verticale è il maschio, che rappresenta la forza, la violenza e il dominio. Tale sensazione è invertita se a essere verticale è la donna, come appunto nella terza foto.
Gli altri elementi sono gli sguardi, che ci comunicano una serie di dati precisi su gli stati d’animo dei personaggi, così come gli atteggiamenti degli arti: un linguaggio corporeo che il nostro encefalo, confrontandolo con un nutrito background culturale è in grado di interpretare agevolmente.
Infine bisogna avere chiaro in mente che tutti questi elementi, che io ho sezionato quasi anatomicamente, non sono parti staccate che vengono poi ricomposte in un’unica intuizione, ma fanno parte di un “unicum” che il nostro encefalo elabora assimilandoli tutti contemporaneamente e ricavandone un’informazione finale che supera, da un punto di vista esegetico, la somma delle singole parti, come ben descritto nella psicologia della Gestalt.
Con le sue fotografie, Nan, non ci restituisce soltanto una registrazione documentale di episodi della sua quotidianità o dell’intimità, a volte controversa dei suoi amici, ma ci rende partecipi in prima persona di forti emozioni, ci spinge al limite di un mondo dove la degenerazione e la più sfrenata libertà di sentimenti divengono prassi e stile di vita. Così la nostra Nan infrange quel sottile diaframma che separa la banalità dal capolavoro, l’ovvio dal geniale. E lo stesso vale per Edward Hopper.